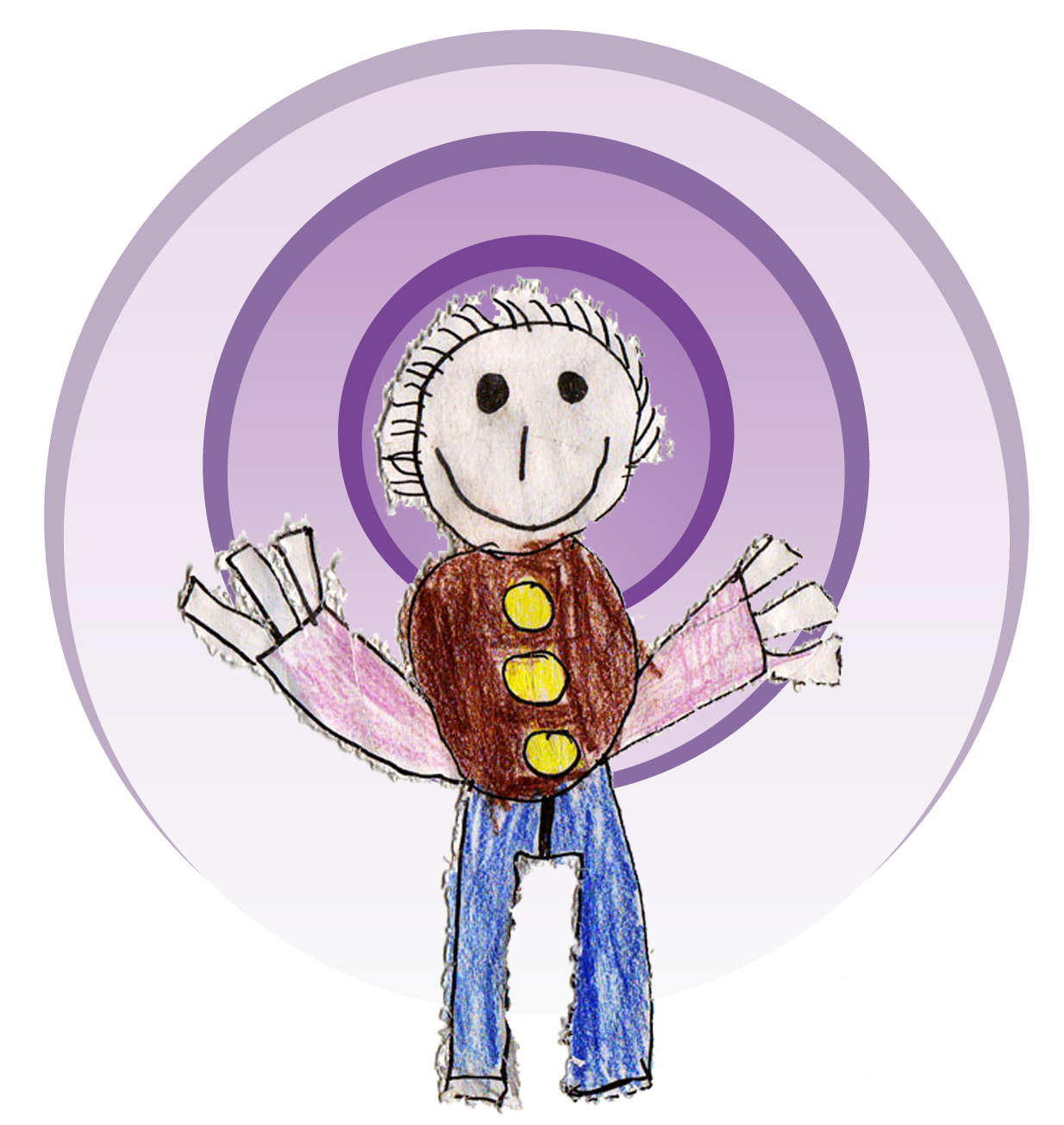Una fiaba dei fratelli Grimm
C’era una volta un uomo che aveva due figliuoli. Il maggiore era intelligente e furbo; aveva imparato tante cose belle; tutto gli riusciva; a tutto sapeva trovar riparo ed in ogni occasione far buona figura. Ma il secondo era uno scemo: e la gente quando lo vedeva passare col suo babbo diceva: «Quello lì gli vuol dar da fare!»
Avveniva per conseguenza, che se al padre occorreva qualche cosa, sempre chiamava il primogenito. Questi era sempre pronto, purchè però non si fosse trattato di uscir di notte e di passare davanti al camposanto. Per certe cose non aveva coraggio e diceva al padre: — Babbo per carità, mi si accappona la pelle!
Quando la sera a veglia famiglia ed amici si raccoglievano intorno al fuoco, e per tenere allegra la brigata v’era chi raccontava di quelle novelle fantastiche e burlesche in cui spesso capitano scene paurose, gli ascoltatori si facevano tra loro la confidenza che giù per la schiena correva loro un brivido, e interrompevano il narratore dicendo ognuno: «Brrr…! mi si accappona la pelle!»
Il grullerello che se ne stava per lo più in un canto, ascoltando, ripeteva fra sè queste parole, e almanaccava come si potesse riuscire a farsi accapponar la pelle. E perchè egli non provava nessuna paura ed a lui non si rizzavano i bordoni, concluse che anche ciò fosse una di quelle tante cose che egli non capiva e non avrebbe imparato mai.
Venne un giorno in cui il padre, stanco di aver in casa un fannullone si volse al figlio minore e gli disse così:
— Dammi retta, tu che te ne stai sempre incantucciato e con le mani in mano: ora sei grande, sei sano e bisogna che anche tu pensi a guadagnarti il pane. Vedi il tuo fratello come s’arrabatta da mattina a sera? Ah! purtroppo con te è fiato buttato via!…
Ma lo scemerello non si sbigottì ed ebbe la risposta pronta:
— Hai ragione babbo: anch’io voglio sapere qualche cosa. Ecco, se fosse possibile vorrei imparare a farmi accapponare la pelle. Lo sento dire a tutti ma non ci capisco nulla!
A queste parole, il fratello si mise a ridere di cuore dicendo fra sè: «Povero ragazzo, quanto è scimunito! Come farà a guadagnarsi da mangiare? Potremo vivere cento anni e non lo vedremo fare una cosa a garbo. Ah! pur troppo, in questo mondo bisogna lavorare e cominciare per tempo. Chi gallo vuol essere, convien che impari a cantare».
Il padre invece sentì una gran pena al cuore e dopo un sospirone tornò a dire allo stupido figliuolo:
— Pur troppo, andando avanti nella vita, ti si rizzeranno i bordoni più d’una volta: ma non per questo guadagnerai il pane!
Quando venne a fargli visita, come suoleva, il sacrestano, esso gli raccontò che quel benedetto ragazzo era la sua croce, che non imparava nulla, che nulla era buono a fare e che gli premeva soltanto di farsi accapponare la pelle!… Aveva proprio bisogno di uno sfogo, povero uomo!
Il sacrestano credeva di esser furbo e gli propose di dargli il figliuolo per un poco di tempo alla canonica, promettendogli che in breve avrebbe imparato a farsi rizzare i bordoni. Lo scemo andò da lui ed ebbe l’incarico di suonare le campane. Dopo qualche giorno, il sacrestano pensò che fosse bene di fargli un po’ di paura. Lo chiamò a mezzanotte e lo fece salire in campanile a fare una scampanata. Poi nascostosi in alto, nella volta scura della torricella, come vide venir su lo scemo per battere il doppio «ora, ora – disse fra sè – te l’ho fatta, povero grullo! Tu crederai che ci sien gli spiriti quassù e ti si rizzeranno i bordoni coi fiocchi».
L’uno suonava e l’altro aspettava d’esser visto per ridere della stupida paura.
Tranquillamente, come fosse giorno, senza temere nè buio, nè solitudine, nè silenzio, lo stupido se ne veniva su e si metteva a suonar le campane, e quando si fu accorto di quella figura che biancheggiava nella volta della torre «Chi va là?» domandò senza scomporsi. Non avendo risposta, continuò: «Cosa ci vieni a fare qui dentro di notte ohè? O scendi o ti butto di sotto».
Il sacrestano stava chiotto perchè credeva che quell’altro dicesse per ischerzo. Ma il campanaro chiamò per la terza volta e siccome nessuno rispondeva, appoggiò una scala al muro, vi si arrampicò ed agguantato il supposto spettro per il collo, lo buttò giù dalla torre. Poi si rimise a suonar le campane tranquillo e contento come una pasqua e come ebbe finito, ridiscese dal campanile, s’infilò nel letto e riattaccò il sonno interrotto.
La moglie del sacrestano, intanto, aspettava il marito da un bel pezzetto e non vedendolo rientrare in camera e non sapendo che diavol facesse, l’andò a cercare per la casa; finalmente, impaurita, svegliò il ragazzo campanaro e affannosa gliene domandò.
— Non ne so nulla io! – le rispose lo stupido. – Ma, ora che ci penso… aspettate… su, nella piccionaia del campanile ho visto qualcuno nascosto. Ho chiamato, ho detto «scendi!», e siccome non c’era verso di avere risposta e quel fagotto bianco non se ne andava, l’ho chiappato e l’ho buttato di sotto. Andate un po’ a vedere se per caso fosse stato il sacrestano!
La donna, spaventata, corse fuori in cerca del marito e lo trovò, infatti, disteso in terra, con le gambe rotte. Naturalmente, come lo ebbe soccorso, andò difilato dal padre del campanaro a raccontargli la cattiva burla del figliuolo: e quegli, cercatolo subito alla canonica, gli dètte una strapazzata ammodo.
— Chi t’insegna, briccone, a far di questi tiri alla gente? Il diavolo, nessun altro che il diavolo! – gridava il povero uomo fuor di sè dal dolore. Ma non c’era verso che quello scimunito rimanesse a bocca chiusa.
— Babbo – disse senza indugio – che ci ho da far io? Chi gl’insegnava a mettersi lì di notte e star duro come un piolo e zitto come l’olio? Io ho creduto che fosse qualche birbante che mi volesse far del male e l’ho levato di mezzo!
E il padre, di rimando, disperatamente:
— Da te non avrò mai altro che dispiaceri e disgrazie! Va’ via, va’ via, che non ti vegga più,
— Sì, babbino, volentieri – riprese il figliuolo con la solita calma. – Aspetta però che faccia giorno per bene e poi vedrai come saprò trovar la strada per andare a farmi accapponar la pelle. Ah! per chi lo sa, dev’essere una gran bella cosa!
— Va’ dove vuoi, chè il cervello ormai lo hai bell’e accapponato, e non c’è più rimedio! – conchiuse il padre. – Tieni questi cinquanta scudi. Te li dò perchè tu vada via lontano e non ritorni più, capisci? Ma bada bene di non dir mai a nessuno nè da dove vieni nè chi è tuo padre, perchè mi fai vergogna, sciagurato!
— Sì babbo, se non vuoi altro che questo sarai obbedito. Son due cose che si tengono facilmente a memoria: non dire chi son io e non dire chi sei tu. Va bene, va bene!
Quando il sole fu alto, lo scemo si mise gli scudi in tasca e se ne andò sulla strada maestra che conduceva lontano. Mentre andava, si strofinava le mani e diceva, discorrendo fra sè: «Ah! se mi riuscirà di farmi accapponar la pelle, sarà una gran bella cosa!»
Un uomo gli passò accanto e udendo sempre ripetere le stesse parole: — Vuoi farti rizzare i bordoni? – gli domandò. Aspetta, ora te lo insegno io. – E come furono andati insieme per un certo tratto e si trovarono in luogo da cui si vedevano le forche, dove pendevano dei giustiziati, – apri bene gli occhi – gli disse – e guarda quei sette penzoloni che hanno fatto le nozze con la morte secca. Li vedi eh? Ebbene ti devi mettere a sedere lì sotto e aspettar che si faccia buio. Non dubitare, appena sarà notte, la pelle ti s’accapponerà senza fatica.
— Davvero? Oh! che bella cosa! Senti: io ci vado e faccio quanto m’hai detto. Ma tu ritorna domattina, chè se i bordoni mi si sono rizzati, ti regalo i miei cinquanta scudi! – Detto ciò, prese la via delle forche e si mise a sedere sotto quei sette impiccati, aspettando la notte.
Intanto lo colse il freddo ed egli pensò che fosse bene fare una buona fiammata. Ma quando fu verso mezzanotte il vento soffiava così forte ed era tanto gelato, che lo stupido per quanto stesse al fuoco non si scaldava.
— Che freddo! – diceva fra sè: e al vedere quei poveretti penzolar così e sbattersi l’uno contro l’altro: – Povera gente! – cominciò a brontolare – quelli lassù devono sentire anche più freddo di me, perchè stanno più in vetta! – Era grullo, ma si vede che non aveva il cuore cattivo perchè mise una scala al castello della forca e salì su per staccare gli impiccati dal palco e metterli in giro intorno al falò che rischiarava quella scena strana. Bisognava vederlo come si affaccendava a soffiar sulle fiamme, acciò quelli infreddoliti si potessero riscaldare. Ma essi rimanevano immobili e freddi e le vesti loro pigliavan fuoco. – Oh! – gridava lo scemo – non vedete, imbecilli, che vi bruciate la roba che avete addosso? Se non badate a’ vostri cenci, vi rimpicco!
I morti stavano sempre fermi e zitti, e le vesti si abbrustolivano.
— Sapete un po’ che cosa v’ho da dire? – riprese quel grullo – se non siete buoni a nulla, io non vi posso far altro. Non voglio mica pigliar fuoco per far comodo a voialtri! – e rimontato sui pioli della scala, riattaccò i cadaveri sulla forca.
Quando fu giorno e l’uomo che gli aveva dato il buon consiglio per farsi finalmente rizzare i bordoni, fu tornato in quel luogo, nella certezza di avere i cinquanta scudi, non voleva credere nè agli occhi nè agli orecchi suoi nel veder il compagno di viaggio così tranquillo e nell’udire come la pelle non gli si fosse accapponata per niente.
— Come vuoi che sappia cosa si fa perchè si rizzino i bordoni? – continuava lo scemo meravigliato – non me l’ha mica insegnato nessuno! Quei sette citrulli sono sempre rimasti a bocca chiusa. Li ho staccati di lassù perchè ho creduto avessero più freddo di me; li ho scaldati; ho fatto per loro tutto quello che ho potuto. Lo crederesti? Sono sempre stati a muso duro; non m’hanno neppur detto «crepa!» Si sono lasciati bruciare que’ po’ di stracci che avevano addosso, e se non era lesto a rimetterli sulla forca, volevi vedere che bell’arrosto!
L’uomo vide bene che per quella volta i cinquanta scudi non gli venivano in tasca, e, voltate le spalle, si rimise per la sua via, dicendo fra sè che un tipo di quella fatta non gli era mai capitato.
Il giovanotto riprese anch’egli il suo cammino, e come prima ricominciò a dire ad alta voce:
— Ah! quando mi si accapponerà la pelle sarà una gran bella cosa.
C’era un carrettiere che se ne veniva dietro a lui col barroccio e udito lo strano desiderio di quello sconosciuto, lo chiamò e gli chiese chi fosse.
— Io? non lo so – fu la risposta.
— Da dove vieni?
— Uhm! non lo so.
— O… il tuo babbo come si chiama?
— Ah questo non lo posso dire!
— O che diavolo masticavi costì fra i denti?
— Eh! dicevo che vorrei farmi accapponar la pelle: ma nessuno mi vuole insegnare come si fa.
— Non ti confondere. Vieni, vieni: te lo insegnerò io, povero figliuolo!
I due si accompagnarono. Quando fu sera, arrivarono ad un’osteria e vi dovevano pernottare. Era appena entrato il giovanotto che ricominciò a brontolare fra sè il solito ritornello: «Ah! se mi s’accapponasse la pelle… che bella cosa!» Lo udì l’oste e fece una risata. Poi: — Se non vuoi altro, gli disse, – io ci ho da proporti una buona occasione, sai!
— Sta’ zitto – gli gridò la moglie – non far brutti scherzi. Non vedi che belli occhi ha questo ragazzo? Sai bene che quanti vi sono passati, sono anche morti dallo spavento. Sarebbe un peccato se morisse questo bel figliuolo, se quelli occhi non si avessero più da vedere!
— Anzi, benone! – esclamò il giovanotto – se ci vuol fatica, tanto meglio! Sono andato via di casa apposta, sapete, per imparare a farmi rizzare i bordoni. Non c’è mica da ridere, nè da far chiasso! – E si diede ad assediare di domande l’oste, acciò gli raccontasse quanto aveva promesso. Questi gli disse come di lì non molto discosto fosse un castello maledetto, dove avrebbe presto imparato a farsi rizzare i bordoni chiunque vi avesse passato tre notti. Il re che dimorava là dentro prometteva in isposa la figlia sua all’uomo coraggioso che lo deliberasse, vegliando per tre notti nel suo castello: e questa figliuola era bellissima. Tra quelle mura paurose si trovavano anche molti tesori, che i fantasmi custodivano e che sarebbero in tal modo liberati.
Quanti finora si erano presentati per porsi alla prova non erano più tornati fuori.
L’indomani, quando fu giorno, lo scemo si presentò a quel re e gli disse:
— Vorrei che mi fosse concesso di vegliare per tre notti nel vostro castello.
A che l’altro lo guardò un poco e visto che non era brutto ragazzo e che pareva buono, gli rispose:
— Va bene. Mi puoi chiedere tre cose, cioè tre oggetti che desideri d’aver presso di te durante queste nottate.
— Domando un po’ di fuoco; un banco da tornio; una tavola da intagliatore con la sua brava sgorbia.
Il re fece provvedere tutto ciò prima di sera. E tosto che fu vicina la notte, il nostro giovanotto tornò su al castello, accese un bel fuoco in una camera, portò la tavola da intagliatore con la sgorbia presso il camino e si sedè sul banco da tornio, aspettando. «Ah! – brontolava intanto fra sè – se mi si accapponasse la pelle che bella cosa! Ma vedo già che anche qui non ne verrò a capo!»
Verso mezzanotte si mise a riattizzare il fuoco e mentre vi stava davanti a soffiare, udì grida e parole che uscivano da un canto della stanza:
— Miau, miau, ohimè che freddo, che freddo abbiamo, miau, brr!…
— Cosa c’è da urlare! – esclamò lo stupido senza voltarsi. – Questa è roba da pazzi. Chi ha freddo si mette a sedere accanto al fuoco e si scalda e non perde tempo a far tutto questo fracasso!
In quella, due gatti neri, grossi e selvaggi, col pelo irto e gli occhi come tizzi saltaron fuori, in un lancio gli furono accanto da un lato e dall’altro e si misero a guardarlo a bocca spalancata e baffi ritti. Egli rimaneva pacifico e seguitava a scaldarsi. Lì, davanti al camino acceso, si scaldavano insieme come fossero tre buoni amici! Poco dopo, i due gatti uscirono in questa domanda:
— Compagno, vogliamo fare una partitina a carte?
— Sicuro! Ma, scusate, fatemi vedere le vostre zampe.
I gatti misero fuori certe grinfie che parevano di tigre.
— Chè, chè! – esclamò lo scemo – queste unghie non sono da giuocatori. Se volete far la partita, bisogna che ve le lasciate un po’ scorciare.
Detto, fatto. Ghermì i gatti per il collo, li portò sulla tavola da intagliatore, e con la morsa li avvitò per le quattro zampe tutti e due così forte che non si poteron più muovere.
— Credevate di farmela, eh? – continuò ridendo. – No, cari amici, per questa volta la partitina la lasceremo stare. Me n’è passata la voglia dacchè v’ho guardato le grinfie. – E ammazzati, i gatti che prigionieri a quel modo non si poteron difendere, andò a buttarli in un fosso.
Però, come si fu liberato da quei due e si volle rimettere a scaldarsi accanto al fuoco, incominciarono a saltar fuori da tutti i cantucci frotte di gatti neri, di cani neri, dal collare di fiamme, tanti e tanti che egli non poteva più nè fare un passo, nè alzare un dito. Tutte queste bestiacce facevano un chiasso indiavolato; saltavano sul fuoco, lo scompigliavano urlando, volevano spegnerlo.
Egli li lasciò fare per un poco, senza inquietarsi, nè sbigottirsi; poi, quando gli parve che fosse ora di finirla, prese la sgorbia e dètte dentro alla cieca in quel mucchio di animali.
— Fuori, fuori di qui, canaglia – gridava, mentre quelli si sbandavano, fuggivano, cadevan morti sotto il ferro tagliente.
Come aveva fatto coi primi due, anche questi prese e buttò là fuori, in fondo al fosso; poi tornò nella stanza si rimise ad attizzare il fuoco e scaldarsi. E lo colse il sonno e cercò se vi fosse un giaciglio dove coricarsi. Scorse, infatti, un letto laggiù nell’angolo, e vi si buttò stanco a dormire; ma appena egli vi si fu disteso per bene, allungando le gambe, il letto cominciò a muoversi e lo condusse in giro per tutto il castello.
— Bene, bene, benone! – gridava lo scemo. – Questo è un bello scarrozzare. Più lesti, avanti, benone… così! –il letto andava via come lo tirassero tante pariglie, su e giù per scalette e scaloni, via, attraversando stanze, saltando soglie e gradini, fin che dètte balda e lo buttò di sotto. Ma egli non si perdette d’animo; raccolse coperte e guanciali e dicendo: – Ora viaggi pure chi ne ha voglia! – tornò nella sua stanza, si fece una cucetta davanti al camino e dormì fin che non fu giorno.
La mattina, venne il re e come lo ebbe veduto disteso in terra a quel modo immobile e silenzioso, credè che gli spiriti lo avessero ucciso e si diede a dire compassionandolo: «Che peccato che sia morto! era un bel ragazzo». A che l’altro, che s’era svegliato, rispose:
— Adagino… non siamo ancora tanto avanti!
Il re tutto meravigliato si fece raccontare come gli era andata.
— Bene – rispose tranquillo il giovanotto – una nottata l’ho già fatta, così passerò quell’altre.
E quando tornò dall’oste, più che mai questo fece le meraviglie, sgranando gli occhi e dicendogli:
— Non avrei mai creduto di rivederti, sai. E… dimmi… ora lo sai cosa si fa perchè si rizzino i bordoni?
— Io?… non lo so davvero. Non me l’ha mica insegnato nessuno!
Di nuovo venne la notte e daccapo lo scemo andò su al castello, brontolando fra sè: «Quando mi s’accapponerà la pelle, sarà una gran bella cosa!»
Egli sedeva, come la prima volta davanti al camino acceso, quando verso mezzanotte cominciò un rumore che divenne un diavoleto d’inferno e tutto a un tratto, dalla cappa del camino cadde giù strillando un uomo tagliato a mezzo.
— Buonasera – disse lo scemo. – Ma così è troppo poca roba, ce ne vuole un altro mezzo. – E ricominciato il fracasso, cadde giù anche l’altro pezzo.
Il buon ragazzo si strofinò le mani e si mise a soffiar sui carboni per far alzare una bella fiamma.
— Aspetta, – diceva intanto – ora ti scalderai.
E, quando si volse, vide le due parti umane che si erano ricongiunte, e un uomo orrendo sedeva sul banco del tornio.
— No, no: – disse allo sconosciuto – questi, carino mio, non sono i patti. Il posto è mio.
E siccome l’altro faceva orecchi da mercante e restava duro, piantato lì a sedere, che cosa fece il ragazzo? Gli dette uno spintone e si sedè dove stava prima, tranquillo come un papa. In quel punto venner giù dalla cappa tanti uomini i quali avevano in mano nove tibie e due teschi e si misero a giuocare con quelli a birilli. Al giovanotto venne il capriccio di giocare con loro e: — Scusate, – domandò – non potrei essere dei vostri?
— Purchè tu abbia danaro – risposero.
— Ce n’ho assai. Ma prima bisogna che veda queste palle. Non mi paiono rotonde e levigate a dovere! – e presi i teschi, si pose al tornio e li arrotondò.
— Adesso sì che gireranno bene! Adesso sì che ci divertiremo!
Giuocarono tutti insieme ed egli perdè qualche moneta. Ma come battè la mezzanotte, tutto era scomparso, ed egli disteso nel letto dormiva pacifico come se niente fosse stato.
Alla mattina di poi, venne il re di nuovo a vedere come erano andate le cose.
— Dunque? – domandò.
— Mah!… ho giuocato ai birilli e perso un po’ di danaro.
— I bordoni si son rizzati?
— Se mi si fosse accapponata la pelle sarei più allegro di quel che mi vedete!
Quando fu alla terza nottata, si sedè al solito posto, nella solita camera, tutto imbroncito e noiato, brontolando fra sè: «Se almeno la facessi questa famosa pelle di cappone!».
Quando fu tarda l’ora e fitto il buio, entrarono sei uomini grandi e forti che portarono una bara e la deposero in terra.
— Bravi! – esclamò il giovinotto – un po’ di compagnia fa sempre piacere. O vediamo, che c’è di nuovo. Dev’essere il mio cuginetto che morì due giorni fa. – Con un dito faceva atto di chiamare, e invitava: – Vieni fuori, caro, vieni! – e perchè questi non si muoveva, scuoprì la bara.
Infatti vi giaceva un uomo morto. Egli incominciò a toccarlo sul viso e sulle mani e perchè lo sentiva ghiaccio, gli andava dicendo che aspettasse un momento, che a scaldarlo avrebbe pensato lui. Andò, infatti, davanti al fuoco, si scaldò ben bene le mani e tornato dal morto gliele posò sulle due guancie. Ma l’altro era sempre gelato.
Visto, allora, che così non era ben fatto se lo tolse in grembo e gli fece delle fregagioni alle braccia perchè gli si rimettesse in circolazione il sangue. Ma non ottenendo nessun resultato si pose a riflettere: — Quando due stanno insieme a letto, si scaldano – e preso il morto in collo, si mise a letto con lui, rincalzando anche le coperte. Dopo un momento quel corpo freddissimo parve farsi a mano a mano tiepido e poi caldo, fin che cominciò a muoversi.
— Ah! lo vedi, cugino – esclamò il giovanotto – se non t’avessi scaldato io!…
Il morto però non parve soddisfatto e rispose:
— Ora ti voglio sgozzare.
— Ah! si? – riprese l’altro – sarebbe questa la ricompensa che mi daresti? Se è così ti rimetto subito nella tua scatola. – E lo afferrò, lo sollevò; lo gettò nella bara e ne chiuse il coperchio a colpo. Dopo di che, tornarono i sei uomini grandi e forti e si ripresero la bara col morto dentro, mentre lo scemo brontolava fra sè imbroncito e noiato:
— Pare impossibile che non mi riesca di farmi accapponar la pelle. Potrei stare qui dentro tutta la vita e non mi riuscirebbe d’imparare come si fa!
In quella entrò un uomo che era ancora più grande e più forte degli altri sei, ed aveva una faccia spaventosa. Era vecchio e la barba bianca lunghissima gli scendeva a terra. Appena entrato gli fece un complimento:
— O scellerato, o furfante… – gli gridò con voce da far rizzar i bordoni per davvero – ora t’insegno io come si fa a farsi accapponar la pelle. Tu devi morire.
— Davvero? – disse l’altro con la solita calma e con un risolino che poteva farlo credere un furbo. – Piano, piano… ci dovrò essere anch’io!
E il vecchione:
— Ora t’agguanto!
— Staremo a vedere. Non far tanto lo spavaldo, chè se tu sei forte, anch’io lo sono e magari anche più di te.
— Proviamo! – replicò il barbuto – se sarò io il più debole nella lotta, me ne andrò e ti lascerò in pace. Se son più forte, guai! Avanti… provati!
Dicendo ciò, lo condusse per anditi scuri e vôlte nere ad una fucina dove il fuoco ardeva. Lì, ghermita un’ascia, con un solo colpo spezzò l’incudine, che cadde in frantumi a terra.
— Se non è che questo, io lo faccio meglio di te! – disse il giovanotto, ed andato ad un’altra incudine, impugnò l’ascia e come ebbe spezzato quella in due, vi strinse dentro il lungo barbone del vecchio misterioso.
— Ora t’ho in mano, bello mio, e a morire tocca a te! – gli disse, e presa una sbarra di ferro, gli lasciò cadere addosso un bel colpo. Il vecchio non morì ma si dètte a supplicarlo che rinunziasse a misurar la forza con lui e in cambio della propria vita gli promise molti regni. Il giovanotto gli dètte ascolto, liberò la lunga barba dalla stretta dell’incudine e menato dal vecchio, andò in una cantina dove questi gli fece vedere tre cassette piene d’oro.
— Di quest’oro, vedi, una parte appartiene ai poveri, una è del re, la terza è tua, – disse il vecchio dal barbone bianco.
Ma ecco che battè la mezzanotte e lo spettro scomparve lasciando il giovanotto solo nelle tenebre.
— Con un po’ di pazienza – pensò – ritroverò la strada. – A tastoni, con la solita calma, piano piano, se ne tornò nella sua stanza, al caldo di un bel fuoco, entrò a letto e russò fino alla mattina.
Quando all’indomani venne il re e gli chiese se finalmente gli si fossero rizzati i bordoni, egli rispose tutto sgomento che non gli riusciva di sapere che cosa fossero!
— È venuto mio cugino: – diceva stringendosi nelle spalle – c’è stato anche un signore con una barba lunga che non finiva mai: un vecchio m’ha fatto vedere molto danaro, ma nessuno m’ha saputo dire come si faccia per avere la pelle accapponata!
A questo racconto semplice, il re disse:
— Ebbene, lo vuoi sapere?… Tu hai sciolto il castello dall’incantesimo e la mia figliuola avrai in isposa.
— Sta tutto bene, – rispose il giovanotto – ma come si faccia ad avere la pelle accapponata non lo so ancora. Non so cosa siano questi benedetti bordoni!
Fu preso l’oro nella cantina e furono celebrate le nozze. Ma per quanto il nuovo re fosse felice con la sua compagna continuava a mormorare fra sè: «Ah! se mi s’accapponasse la pelle sarebbe una gran bella cosa!»
Alla regina, a lungo andare, venne a noia questo discorso e seriamente si accuorò di vedere come il marito non fosse pienamente contento vicino a lei ed avesse ancora qualcosa da desiderare.
— Aspettate maestà: – le disse la sua cameriera più fida – se lasciate fare a me, lo guarisco io il vostro sposo!
La regina acconsentì.
L’altra, allora, mandò a prendere un secchio d’acqua e lo fece riempire al rio che attraversava il giardino e di cui l’acqua era freddissima e piena di pesciolini; e quando fu notte entrò pianissimo nella camera da letto del re e della regina.
— Maestà sussurrò all’orecchio di lei la cameriera – tirate via le coperte al re e lasciatemi fare, ma zitto, mi raccomando!
La regina tolse le coperte e l’altra, senza indugio, giù rovesciò il secchio addosso al re che dormiva la grossa. Questi si svegliò di soprassalto al sentirsi dappertutto quell’acqua fredda e quei pesciolini guizzanti che gli facevano il solletico, cominciò a gridare:
— Ohi, ohi!… mi si accappona la pelle, mi si rizzano i bordoni! Finalmente lo so anch’io cosa ci vuole per farsi venire la pelle di cappone! Sposina mia, ti ringrazio!
E fecero tutti una risata. Anzi, se non sbaglio, ridono ancora.