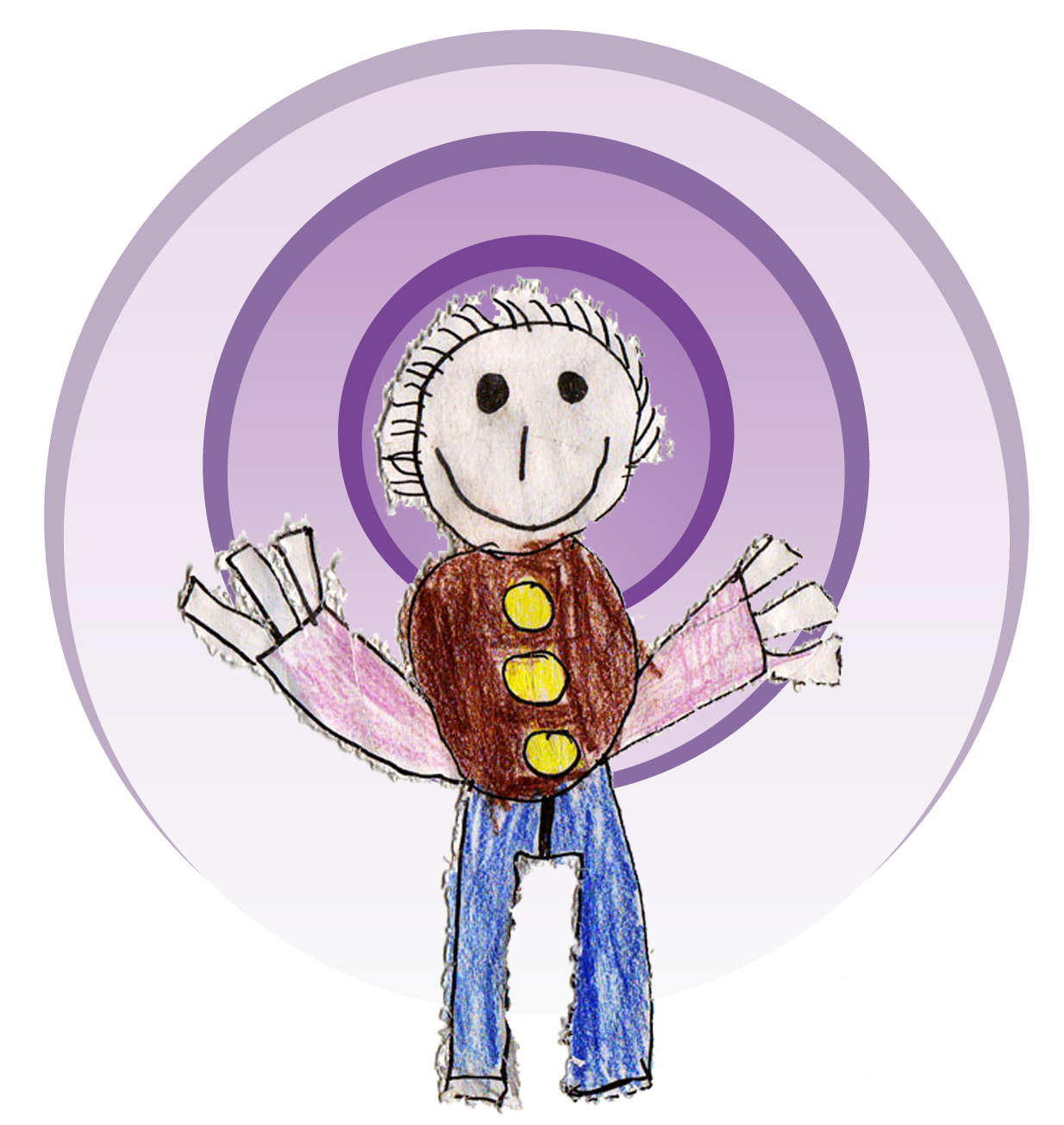Una fiaba dei fratelli Grimm
C’era una volta una foresta immensa, dove gli alberi erano fitti, fitti ed in mezzo sorgeva un antichissimo castello che era tutto nascosto fra le piante.
In questo castello abitava una vecchia maga che durante il giorno si divertiva a trasformarsi in gatto o in civetta per far parecchie brutte burle alla gente e soltanto quando era notte e buio pesto riprendeva le forme naturali. Con la sua virtù misteriosa e malefica, la vecchiaccia attirava i conigli, le lepri, gli uccelli; e quando queste bestioline le erano corse intorno, e le facevano festa, quali scodinzolando, quali muovendo le orecchie ed il musino, altre gorgheggiando e battendo l’ali, essa le ammazzava e se ne faceva vivande squisite, cucinandole in tutte le regole e divorandosele con un appetito da fare invidia al più gran ghiottone di questo mondo.
Se avveniva che creature umane si avvicinassero a cento passi dal suo castello, tutto ad un tratto erano colte dalla malìa; rimanevano là immobili fino a che ella non si fosse sbizzarrita e le liberasse dall’incanto. Ma per le fanciulle non vi era scampo. Erano tutte trasformate in uccelli rari, messi in belle gabbiette e portate in un salone del castello. V’erano già settemila gabbie e settemila uccellini dalle belle piume colorate e dorate, là, nel salone di quel castello.
In un paesetto non molto discosto, viveva una ragazza bellissima, per nome Jorinda, che era fidanzata ad un giovanotto, bello al pari di lei, chiamato Joringhello. Que’ due si volevano un gran bene e volentieri se ne andavano talvolta a spasso insieme per la campagna, discorrendo del più e del meno, e, come sogliono i promessi sposi, cercando i luoghi più poetici, al rezzo delle piante, in mezzo ai fiorellini selvatici e dove gli uccellini fanno i loro concerti musicali a giornate intere senza soggezione di nessuno.
Ecco che un giorno, questi promessi sposi vollero fare una passeggiata nuova e attratti dall’ombra, dalla frescura e dai gorgheggi, si avviarono proprio verso la foresta della maga dove tutti allegri e contenti entrarono e si inoltrarono.
— Sta’ attenta di non avvicinarti troppo al castello! – disse Joringhello, che, a quanto pare, era un giovanotto accorto e conosceva la storia delle metamorfosi.
Ma era l’ora del tramonto. I due vagavano parlando dell’avvenire senza curarsi del sole che calava piano piano affacciandosi a quando a quando tra le fronde e gettando qua e là piccoli anelli di luce, mentre la tortora gemeva malinconica sulla vetta del vecchio faggio. Anch’essi furono colti dalla tristezza dell’ora, nell’ombra verde della selva e, sedutisi su di una zolla dove l’ultimo raggio del sole cadeva, incominciarono a sfogarsi in pianto ed in lamenti. La tortora tubava solitaria e Jorindo e Joringhello, in uno sbalordinento sempre crescente si guardavano intorno senza sapere quale fosse la via per tornarsene a casa. Tutto ad un tratto, Joringhello vide attraverso le vette degli abeti, le torri del castello incantato. Lo colse un’angoscia di morte, ma non potè più muoversi per fuggire e salvarsi. E un usignuolo cantò con tenerezza infinita. Egli si volse, guardò quell’usignuolo… la sua Jorinda era sparita e le note di quell’uccellino gli dicevano come la maga avesse operato la metamorfosi.
In quella una civetta con gli occhi gialli pieni di fiamme svolazzò intorno stridendo in tuono di canzonatura «hu, hu!». Il giovanotto non si poteva muovere; era come di pietra. Non piangeva, non parlava, non alzava neppure un dito. Pareva una statua. Scendeva la notte.
La civetta starnazzò sopra un cespuglio e ne sbucò fuori una vecchia allampanata, secca, lunga, gialla, gobba, sbilenca, sciancata che aveva gli occhi rossi e il naso adunco così che le beccava il mento. Borbottando chi sa quali parole, agguantò l’usignuolo e se lo portò via. E quel povero ragazzo sempre lì immobile, vedeva tutto e non poteva dire una parola, nè fare un gesto per salvare la fidanzata! Aspetta, aspetta, nulla si mutava. La notte era, la notte stava; Joringhello pareva di pietra.
Dopo un bel pezzo tornò la vecchia e, rivolta a lui gli disse con voce roca:
— Buona sera, Ezechiello! – Quelle erano le parole che scioglievano l’incanto.
— Che le frulla pel capo di chiamarmi Ezechiello! – pensò il giovanotto. E sebbene avesse voglia di leticare, si buttò in ginocchio ai piedi della maga, la pregò, la supplicò di aver pietà di lui e di Jorinda, e di rendergli la sua promessa sposa. Ma non valsero nè parole, nè lagrime.
— Jorinda è mia e me la tengo! – chiocciò la brutta vecchia e gli volse le spalle.
Joringhello disperato, si avviò per un sentiero, non sapendo quello che si facesse. Cammina, cammina, stanco, affannato, col cuore in brandelli, arrivò finalmente in un villaggio e per campar la vita si fece guardiano di pecore. Con le sue pecore, ogni giorno quel poverino si aggirava intorno alla foresta e vi si affacciava, sempre attento per non avvicinarsi al castello, stava in orecchio per sentire se gli giungeva il canto del suo usignuolo. Poi tornava via, sconsolato, con la solitudine nell’anima.
Una notte fa un sogno. Ha trovato un fiore che è rosso come il sangue ed ha in mezzo alla corolla una perla. Egli ha colto quel fiore, è andato al castello e tutte le cose che tocca con quel fiore sono liberate dalla malìa. Così salva e rivendica Jorinda sua.
Appena fu sveglio, si dètte a cercare per monti e per valli quello strano fiore miracoloso. Cerca, cerca, non trovò nulla. Stanco, affannoso, tutto grondante sudore, cercò ancora, cercò sempre. Su e giù per le alture, di qua, di là, nel piano, senza posa, senza avvilirsi. Così per nove giorni. Alla mattina del nono giorno trovò il bel fiore color scarlatto, a cui la rugiada aveva posato in seno una goccia, grande, purissima come una perla.
Joringhello lo colse, e se ne andò al castello. Oh! che viaggio lungo e faticoso per arrivarvi. Chi sa in qual paese era arrivato nel suo ramingare!
Pieno di fede nel suo bel sogno, pieno di fede nel suo bel fiore, cammina, cammina; valica monti, attraversa pianure, risale colline e poggi, ridiscende pendici, arriva finalmente alla selva grande e fitta, arriva al castello della maga. A cento passi distante, si ferma immobile come una statua. Ne va diritto fino al portone, lo tocca col fiore e quello subito si spalanca. Joringhello entra, attraversa il cortile e sta un momento in ascolto per capire da quale parte sono gli uccelli rari. Origlia, trattiene il respiro… Ah! il core gli dà un balzo! Gli uccelli cantano, egli li ha uditi, si avvia verso quel lato da cui vengono a lui i loro gorgheggi, entra nel salone delle settemila gabbie e vede la vecchia che fa il giro di tutte e portando il becchime alle bestiuole.
Appena essa lo vede, si dà a gridare, esce in ismanie, in furie, sputando fiele e veleno, sempre ferma al suo posto, chè una virtù più forte della sua magìa ve la tiene inchiodata. Egli, a testa alta, col passo spigliato e l’occhio fiero, sprezzando gli urli di quella forsennata, guarda ad una ad una tutte le settemila gabbie. Come può ritrovare la sua Jorinda? Gli usignuoli vi sono, nientemeno che a centinaia! Mentre cerca, vede la vecchia che fa sforzi per allungar la mano verso la gabbietta e dirigersi verso la porta. Svelto, corre verso di lei quando essa già ha in pugno l’anello della gabbia. Egli ne tocca col fiore meraviglioso le sbarre, tocca la vecchia che rimane priva del suo potere e Jorinda torna ad essere una bella fanciulla mille e mille volte più bella di prima. Ella felice e sorridente abbraccia il fidanzato benedicendolo per la propria liberazione: e tutti i settemila uccelli al contatto del fiore di Joringhello tornano allo stato primiero, liberati dall’incanto della perfida maga. E dopo?
I promessi sposi si presero a braccetto e ritornarono al paese dove tutti li festeggiarono. Presto furono fatte le nozze e Jorinda e Joringhello vissero felicissimi per una lunga fila di anni.